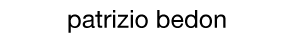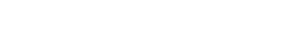Presentazione
È sorprendente come si sia sempre poco riflettuto sulla differenza tra un brutto quadro di un artista noto ed un bellissimo tappeto di un artigiano ignoto. Alla manualità creativa è sempre stata riconosciuta poca dignità. Mentre ancora furoreggiavano le pensate post-moderne nei primi anni ottanta, decisi di imparare a tornire il legno e andai a scuola da uno dei tre o quattro vecchi tornitori che ancora avevano bottega a Milano. Per un architetto è stato un po’ come andare a sciacquare i panni in Arno. Facevo piatti e scodelle. Poi mi misi a scolpire pipe realizzando texture ibride, veli superficiali avvolgenti tra il vegetale e la fibra muscolare. Solo l’interno del fornello era tornito. Lavoravo in un localino di tre metri per uno e mezzo. Un laboratorio abbastanza spazioso lo ebbi solo quando mi trasferii al Cerro. Ciò mi permise di trasmigrare dal mono-micro (le pipe) al multi-macro (lampade, mobili, sculture). E nel frattempo passavo dalla materia grezza comprata (le placche di radica delle segherie Cresci di Sassetta) ai materiali di recupero trovati e raccolti: un modo in più di dare dignità simbolica al “senza valore”.
Per lavorare come faccio io bisogna guardare per terra e raccattare l’insignificante, il frammento dimenticato, il pezzo di legno portato dal mare, dai fiumi, dal lago. Ci possono essere segni di lavorazione. Di usura, che rimandano a vite e storie sconosciute; oppure c’è la sola natura che si propone in veste trasfigurata dal vento, dall’acqua e dal sole: il ramo allora non è uno scheletro, è un’anima che tocchi. Nei cumuli di metallo dimenticati affiorano pezzi di ottone, di rame, di zama, di ferro. Anche qui le provenienze e le storie sono incerte, tuttavia si può sempre riconoscere ciò che arriva dal salotto buono, dalla portineria, dal design (buttato), da qualche vecchia cascina sparita nella periferia violentata e urbanizzata (chiodi vecchi, un chiodo fisso). Così nascono piccole storie ricomposte col gusto del rammendo e dell’imperfezione, che non è solo una tecnica povera dei tempi passati, ma un modo di intendere la vita e forse il futuro. Si rammenda sulle ingiurie del tempo e degli uomini e nasce qualcosa di nuovo che non ha le pretese perfezionistiche della creazione pura sulla materia informe, ma la densità lirica delle immagini primordiali. Si cerca di fare pace col tempo, con Kronos che divora i suoi figli, provando perfino a fermarlo sulle lancette di un orologio bloccato. A vele spiegate partono navi già naufragate e si gioca con le macchine del tempo, illuminati da lampade totemiche che, se anche fanno luce, soprattutto fanno compagnia, come persone. Perché mi piacciono gli oggetti che parlano, che siano sculture o oggetti d’uso poco importa: la distinzione non credo abbia senso, come si comincia a capire. Il linguaggio urlato della denuncia trucida, e quell’altro, sussurrato, della supponente ironia, lo lascio a passate esibizioni o sempreverdi adolescenze prolungate che non mi appartengono. Tutto si può dire con delicato lirismo. Una carezza al mestiere di vivere. Ci ho provato, sempre affascinato dal valore fondante dell’imperfezione.
Patrizio Bedon, architetto.
Nota
La classificazione delle opere in gruppi (più o meno convenzionali) obbedisce unicamente ad una necessità pratica di orientamento approssimativo. È ovvio che il superamento della cesura tra oggetto d’uso e oggetto d’arte rimane una delle intuizioni fondanti di tutto il mio lavoro. Per questo motivo è fatale che la classificazione in gruppi adottata possa apparire contraddittoria, mentre certamente è asistematica.
Tutti gli oggetti che presento sono stati realizzati in un arco di tempo compreso dal 2000 a oggi.